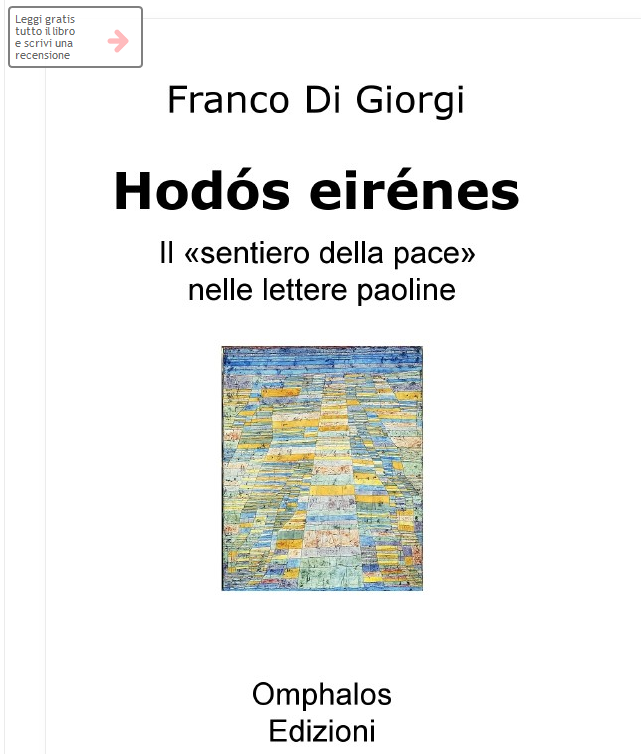Coronavirus
A che punto è la notte?
da’ al tuo dolore le parole che esige
(Macbeth, atto IV, scena III)
La velocità di diffusione di un virus che infetta le vie respiratorie di un essere umano fino a provocarne la morte è forse minore rispetto a quella con cui l’impollinazione e la disseminazione riproducono la vita. Quando però l’equilibrio coevolutivo tra differenti esseri viventi viene stravolto da una innaturale osmosi tra diverse specie di animali, allora la rapidità di quella diffusione aumenta rispetto alla riproduzione della vita. Da tempo, a fronte di segni evidenti di squilibrio naturale, gli esperti ci ripetevano quello che oggi purtroppo ci confermano: un tale squilibrio è provocato dall’evoluzione ecologicamente irresponsabile della specie umana, la quale ha nel frattempo imparato astutamente a difendersi da pericoli virali simili, cioè a differire nel tempo un’estinzione che meriterebbe per i danni che ha arrecato all’ecosistema, avendo approntato rimedi farmacologici in grado di proteggersi dai virus, ma non di liberarsene definitivamente. Già questo legittimerebbe a dire che la veloce diffusione virale della morte non è altro che il conseguente rovescio della medaglia, ossia il processo opposto a quello altrettanto veloce in cui si propaga la vita sulla terra; e che dovremmo almeno imparare a espiare le nostre colpe cominciando a ripetere le parole di Giobbe: «Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore! […] Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?» (Gb 1, 21; 2, 10).
La natura dell’agente patogeno sembra allora essere analoga a quella che ha il male per gli Epicurei e per Lucrezio, vale a dire razionalmente contrastabile, ma non eliminabile. Incapaci di autoriprodursi, questi virus sono dei parassiti che per sopravvivere e moltiplicarsi hanno bisogno delle cellule, di microrganismi vegetali o animali. Sicché senza un vaccino che possa frenarne o arrestarne il veloce ciclo riproduttivo dopo un periodo di incubazione, la loro infezione, cioè la loro azione patogena, può provocare altrettanto velocemente la morte degli organismi ospitanti. Così facendo, queste entità, che sono dell’ordine dei nanometri e che si possono considerare al confine tra il mondo dei viventi e il mondo dei non viventi, riescono ad assimilare a sé gli esseri umani, trasformandoli, anche solo nell’attesa forzosa e ansiosa della quarantena in casa, in altrettanti enti eraclitei oscillanti tra il vivente e il morente. Molti degli infettati infatti non sanno di esserlo e questa ignoranza è lo stratagemma che il virus usa per aggirare la nostra astuzia e per potersi propagare. Ma è grazie all’intelligenza, si legge ancora nel Giobbe (Gb 28, 28), che l’uomo può schivare il male che gli giunge dalla sua ignoranza; l’uomo che, si legge nel secondo coro dell’Antigone, pur non trovando scampo alla morte sa tuttavia trovare rimedio anche ai mali immedicabili.
Come si vede, anche a questo livello biologico, siamo dinanzi a una lotta intima fatta di mosse e di contromosse tra il vivente e il non vivente, tra la vita e la morte. E se con Macbeth ci chiedessimo «A che punto è la notte?», con Lady Macbeth potremmo rispondere: «Prende a lottare con il mattino, per decidere qual dei due prevalga». Solo che, direbbe Malcolm, «Lunga è quella notte che non riesce a trovare il giorno». Ci viene in mente il Macbeth solo perché lo abbiamo riletto di recente in vista della rappresentazione del 5 marzo al Teatro Stabile di Torino, saltata purtroppo proprio a causa del Coronavirus. Si tratta di astuzie, di inganni e tradimenti che in ogni tempo affliggono l’earthly world, il «mondo basso» in cui vivono gli uomini e nel quale, dice Lady Macduff, «le cattive azioni son spesso lodate, così come le buone s’hanno la reputazione di perniciosa follia»; un mondo (la Scozia degli inizi del Seicento) da cui il marito, il nobile Macduff, era fuggito disgustato dai vizi (evils) che ammorbavano la sua patria.
E in effetti, pur non potendo oramai sfuggire all’onda avvolgente del virus, a un simile autoesilio spingerebbero le basse astuzie di qualche nostro politicante, usando il proprio personale cavallo a dondolo come un cavallo di Troia: chi inserendo astutamente membri del proprio neonato partito nella compagine governativa, chi volendo a tutti i costi, in quanto opposizione, essere inserito nei prossimi dpcm, in modo da poter così predisporre le cose per il proprio futuro e, quel che è peggio, anche per quello dell’intero Paese. Sfortuna vuole infatti che tutta questa emergenza virus stia facendo andare le cose proprio nel verso che vorrebbero i sovranisti. Una volta superata questa crisi, approfittando dell’emergenza sbarchi, passata in secondo piano in questi giorni di lutto e di abbandono, essi sicuramente rimetteranno con maggior vigore il piede sull’acceleratore della paura e ogni loro richiesta in merito alla chiusura nei confronti di stranieri e migranti non potrà che essere assecondata. Dopo l’emergenza del Coronavirus riemergerà dunque l’emergenza dei flussi migratori, ma questa volta troverà ancora meno persone ad occuparsene, perché molti avranno timore di un qualsiasi contatto con gli stranieri, anche se il pericolo – questo ci ha almeno insegnato il Covid-19 – continuerà a provenire da noi stessi. Oltre all’emergenza virus e a quella migratoria, dovremo dunque ben presto ritornare a fare i conti anche con quella terza emergenza che abbiamo dovuto necessariamente accantonare, cioè quella altrettanto subdola dell’avanzata dell’estrema destra nel mondo. Anche questa è infatti una pandemia virale.
30 marzo 2020