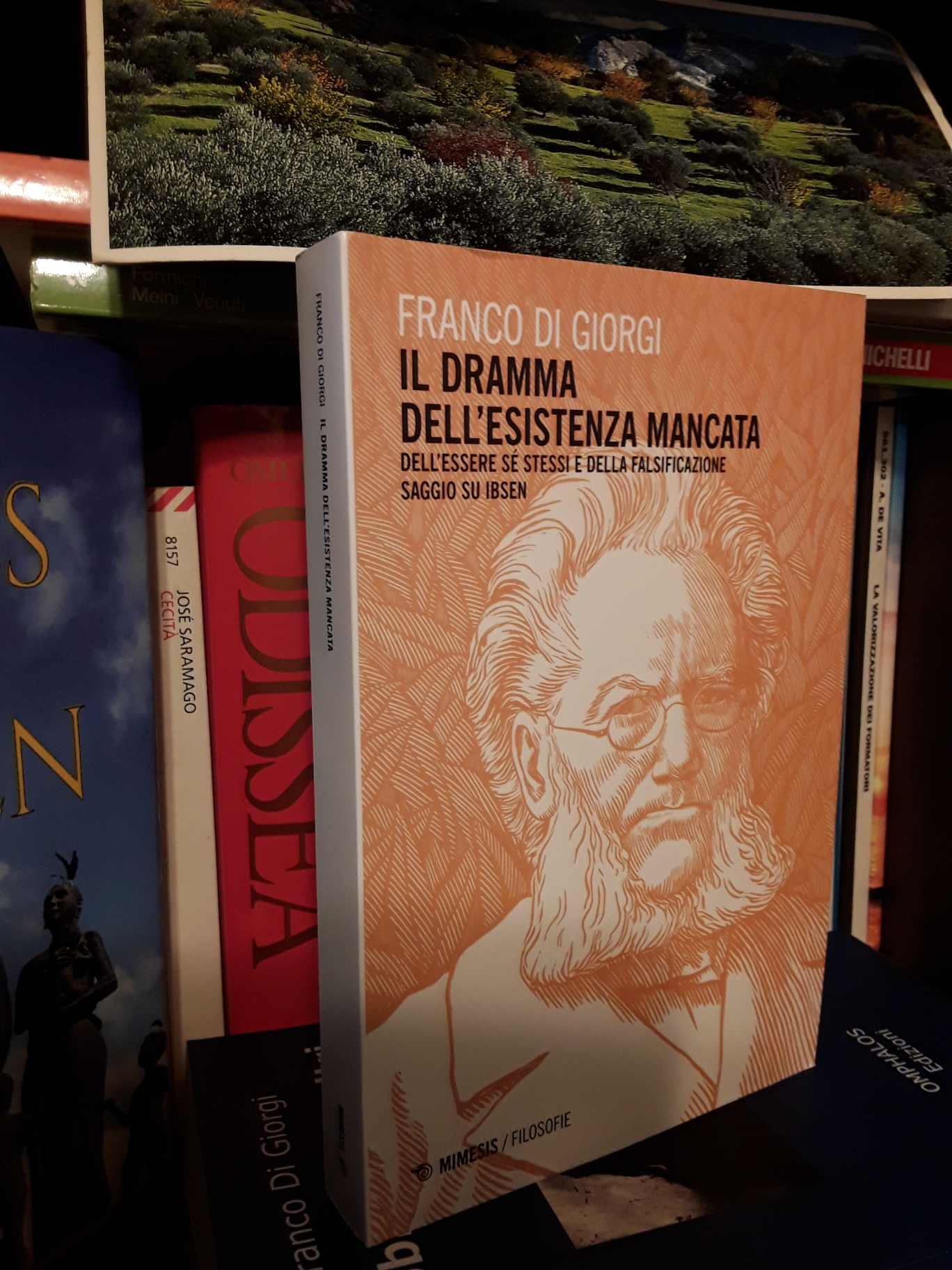Qualche sospetto
QUALCHE SOSPETTO NELL’ATTUALE CRISI POLITICA
Franco Di Giorgi
Nella storia della politica la strenua intransigenza rivoluzionaria e riformista, l’amore per la coerenza a tutti i costi, pur non volendo, ha spesso consegnato, in modi, tempi e contesti diversi, il popolo di una nazione alle forze reazionarie.
Si pensi alla fine che, a partire dal 1794, il montagnardo Robespierre, l’Incorruttibile, ha fatto fare alla Repubblica francese.
Oppure, alle conseguenze che ebbe la scissione del partito socialista a Livorno nel 1921.
O ancora, più vicino a noi, la rottura di Bertinotti dal governo Prodi nel 1998.
Eppure oggi in Italia tutti possono vedere che si può ottenere il medesimo risultato anche con il contrario dell’intransigenza, cioè con l’inestirpabile trasformismo che, nel caso in specie, è anche impudico opportunismo politico.
E ciò fino al punto di indurre un’intera classe politica ad annientare sé stessa, fino all’auto-interdizione, alla resa, a un plateale harakiri.
Tuttavia, qui da noi, culturalmente poco avvezzi al senso del tragico, un Sansone non potrebbe morire mai con tutti i filistei, schiacciato sotto le colonne del palazzo del potere.
Quanto accade e si ripete con una certa frequenza dalle nostre parti, soprattutto a causa di una pessima legge elettorale, induce piuttosto a pensare non già al possente eroe giudeo, ma a figure viscide come quella dello Jago shakespeariano, capaci di muoversi a loro agio nei meandri di leggi come quella, capaci come un ragno di tessere trame in grado di suscitare sentimenti deleteri e distruttivi, tali che, com’è noto, condurranno alla morte sia Otello sia l’innocente moglie di questi Desdemona.
Ma proviamo a ripercorrere per grandi linee la vicenda, prendendo spunto da alcuni momenti significativi della travagliatissima gestione del secondo governo Conte, momenti che destano qualche legittimo sospetto.
Già al momento del suo concepimento, la maggioranza governativa si costituisce anzitutto grazie all’appoggio decisivo di Italia Viva.
In tal modo per il segretario di questo piccolo partito si profila l’irripetibile occasione tanto attesa di usare l’arma del ricatto per poter finalmente appagare la sete di vendetta del suo ego per le battaglie politiche precedentemente perdute.
In virtù di questo grimaldello, egli avanzava al governo richieste e critiche che, per quanto bizzarre, faceva discendere dal suo personale senso di responsabilità.
La sicumera che sgomitando ostentava destreggiandosi impettito in queste continue e diverse richieste lasciava supporre che in sé egli maturasse un’idea delirante, quella secondo la quale così come aveva fatto nascere il governo allo stesso modo non avrebbe avuto scrupolo alcuno nel farlo cadere.
E così è stato.
Il secondo sospetto riguarda l’opposizione. Anch’essa non si limitava più a porre critiche legittime al governo, ma si rifiutava di collaborare nella difficile gestione della pandemia, ostacolandone sistematicamente ogni provvedimento e assumendo platealmente posizioni persino negazioniste.
A fronte di quanto accadeva nelle altre nazioni, qui da noi i sovranisti impedivano l’azione di governo, sicché, ad esempio, quando si parlava di chiusura loro erano per l’apertura e viceversa.
In tal modo il governo doveva far fronte a due critiche contemporaneamente, una interna e una esterna.
Critiche che col passare del tempo assumevano curiosamente un’analoga forma se non addirittura la stessa tattica ostruzionistica.
Infatti, pur derivando da due fazioni opposte, queste due critiche ben presto finirono con il sommarsi, formando un fronte unico e assumendo la comune strategia tesa a far cadere il governo.
Come se entrambe avessero ben chiaro in mente l’obiettivo che intendevano raggiungere, avessero già in serbo una nuova figura di primo ministro.
E tutto ciò nel frattempo facendo finta che la crisi pandemica, con tutto il suo pesante carico giornaliero di morti, non esistesse.
Contrapposizione politica che finì inevitabilmente con il riflettersi non solo sul dolente fronte critico del rapporto Stato-Regioni, ma anche sul fronte epidemiologico, con la dialettica semiseria tra virologi ottimisti a favore dell’apertura e infettivologi pessimisti che propendevano per la chiusura, creando così ancora più incertezza nei cittadini.
Ma i sospetti cominciano a prendere corpo e a rendersi visibili dopo che il presidente ancora in carica Conte riesce a convincere l’Europa a concedere all’Italia un cospicuo fondo finanziario di 209 miliardi di euro per fronteggiare le crisi e per pianificare la ripartenza del Paese.
Solo dopo aver ottenuto questo fondo – cosa che a nessuno dei politici italiani e tanto meno ai leader delle due opposte opposizioni sarebbe mai riuscita, nemmeno nei sogni –, i due Mattei secondo il loro schema tattico, cominciarono di concerto a martellare, a chiedere altro, ancora e sempre altro: ora ad esempio volevano in coro il Mes.
E così, non potendolo evidentemente fare l’opposizione esterna – la quale, visti i sondaggi sul voto, continua imperterrita a chiedere elezioni anticipate –, ecco che a dare la spallata decisiva al governo è l’opposizione interna, nella persona del suo leader, che nella conferenza stampa del 13 gennaio annuncia il ritiro dei suoi ministri dal governo, aprendo così di fatto la crisi di governo.
Il 18 e il 19 l’attenzione dell’intero Paese viene pertanto deviata dall’emergenza Covid all’emergenza politica.
In effetti le due crisi si sommano, la pressione sull’Italia si raddoppia, assume un grave peso.
A causa dunque di una mossa troppo pericolosa per non suscitare qualche sospetto sulla sua arbitrarietà, compiuta da qualcuno la cui sicumera lascia sospettare che non si muovesse affatto al buio, l’Italia sta insomma per scivolare verso qualcosa di incerto (almeno per il popolo italiano), ritrovandosi dinanzi a problemi decisivi che ancora una volta dovranno essere affrontati e risolti dal Presidente della Repubblica, a un anno esatto dalla fine del suo mandato.
Due sono a questo punto i fattori che hanno reso evidenti lo scopo e la tattica assunta dalle due opposizioni, elementi che ormai vengono fatti propri dalla quasi maggioranza dei deputati e dei senatori: uno linguistico e uno, appunto, tattico.
Tranne le forze politiche che sostenevano il governo e qualche altra piccola componente parlamentare, il resto dei politici ha perlopiù adottato un linguaggio duro ed offensivo contro la figura del Presidente del Consiglio (definito “avvocato” in senso sminuente e spregiativo):
un linguaggio usato come un martello al solo scopo di demolirne la resistenza.
Caduto lui, a forza di martellare con parole sempre più pesanti, sarebbe caduto tutto il governo: ecco la tattica strategica.
Sicché, accecati dall’ira e rassicurati dalla loro vittoria dopo le dimissioni di Conte il 26 gennaio (l’esplorazione del Presidente della Camera Fico, dal 30 gennaio al 2 febbraio, sarà solo una proforma prevista dal protocollo), era inconcepibile da loro una pur minima idea di riconoscenza per un governo che, commettendo inevitabili errori, ha dovuto sobbarcarsi la fatica e il lavoro “sporco” che l’inatteso tzunami della pandemia ha comportato.
Ma a questo punto non si può non rilevare una contraddizione nell’azione dei demolitori.
Infatti, pur essendo per un governo “forte”, sostenuti in ciò sia dai media che di parte della intellighentia critica, essi vedevano nei Dpcm uno strumento di accentramento politico, l’espressione di un potere personale che non teneva conto del Parlamento.
E ciò dimostra ancora una volta che gli oppositori trasformavano ogni cosa in pretesto per chiudere definitivamente i conti con il Presidente del Consiglio in carica e con il governo tutto.
A proposito del sostegno dei media, questa fretta nel mettere fine alla coalizione di governo, nonché la sicumera e la sfrontatezza verbale degli oppositori risultavano a volte comprensibili dal fatto che ogni tanto, mentre il governo arrancava sotto il peso dell’impegno gravoso, qualche giornalista, con un sorrisetto presupponente, evocava il nome di Mario Draghi come di un possibile e auspicabile salvatore della patria, come di un condottiero valoroso che da qualche tempo attendeva alle porte della città per intervenire con il suo esercito nel caso fosse necessario.
Ora, a cose fatte, a crisi avvenuta, queste voci giornalistiche si possono leggere come un preannuncio, seppur vago, di quanto accadrà il 13 gennaio.
Come se tra queste voci dei media, la conferenza stampa del leader di Italia Viva e l’incarico conferito il 3 febbraio dal capo dello Stato all’ex presidente della Banca Centrale Europea vi fosse un legame sottile e quasi invisibile: un preaccordo, un “piano B” una volta fallito il “piano A” riguardante il possibile terzo governo Conte.
Come se il destino di quest’ultimo fosse simile a quello di Giobbe, perché, come si è detto, molti elementi lasciano sospettare che tale destino fosse già stato previsto nelle sfere iperuranie.
Scenario questo in cui Renzi appare come il Satana di turno, usato anche in questo caso da Yahweh o dai Signori dell’alta finanza per mettere alla prova non solo il governo giallo-rosso, ma anche per verificare la tempra dei singoli esseri umani, per giocare insomma con le loro vite, la cui qualità esistenziale scompare ogni sera dietro l’annuncio quantitativo del numero dei morti per Covid (il cui totale ammonta ormai a quasi cento mila).
Al contrario dell’Avversario biblico, che non si arroga il merito di aver messo in crisi l’Uzita e con lui l’intera città di Uz, Renzi lo rivendica e come, dicendo in giro (persino in Arabia Saudita) che lui quella crisi l’ha suscitata non per sé e per le sue mire personali, ma per senso di responsabilità, per il bene del Paese.
Eppure dalla sua cieca fiducia nei confronti di tutto quello che fin qui il Salvatore si è limitato solo a sussurrare, risulta ben evidente che l’opzione Draghi soddisfaceva sia lui che l’altro Matteo, in quanto, ognuno per il proprio interesse, pensano vivamente di ottenere, con le loro esibite adulazioni, un importante incarico nel prossimo governo.
Nello splendore celeste di cui questo Professore pare circonfuso essi e tutti i loro amici oppositori cercano una luce in cui poter estinguere il buio in cui si agitano gesticolando umidicci; nella sua imperturbabile placidità agognano il mare in cui annegare la loro irrefrenabile irrequietezza; nella sua inarrivabile maturità essi vorrebbero nascondere la loro evidente Unmündigkeit, la loro immaturità; nella sua estatica beatitudine sognano persi un’oasi in cui ricercare la loro felicità perduta e la loro libertà ceduta.
Per questo motivo, alla fine della loro affannosa corsa, nonostante l’apparizione di santa Dorotea o di san Maturino, forse troveranno ad attenderli le bolge concentriche dell’ottavo o del nono cerchio dell’Inferno, dove Dante colloca i fraudolenti verso chi si fida, i traditori e gli arroganti.
Proprio per questo, ammoniva Primo Levi, si deve sempre diffidare dei “leader carismatici”, specie di quelli che hanno facilità di parola.
Essi, diceva in un intervento del 1986, pensando al duce e al Führer, «possedevano un potere segreto di seduzione che non derivava dalla credibilità o dalla fondatezza delle cose che dicevano, ma dal modo suggestivo in cui le dicevano, dalla loro eloquenza, abilità istrionica, forse innata, forse acquisita pazientemente con l’esercizio.
Le idee che proclamavano non erano sempre le stesse e in generale si trattava di idee aberranti o sciocche o crudeli. Eppure erano osannati e seguiti fino alla morte da milioni di fedeli».
Ivrea, 11 febbraio 2021

Dichiarazione del Prof Mario Draghi al termine del colloqui con il Presidente Sergio Mattarella,al Quirinale
(foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
Download articolo di Franco Di Giorgi intitolato Qualche sospetto nell’attuale crisi politica:

Visite: 71

 In qualità di insegnante di Storia e Filosofia, ha lasciato un’impronta duratura nel mondo della scuola.
In qualità di insegnante di Storia e Filosofia, ha lasciato un’impronta duratura nel mondo della scuola.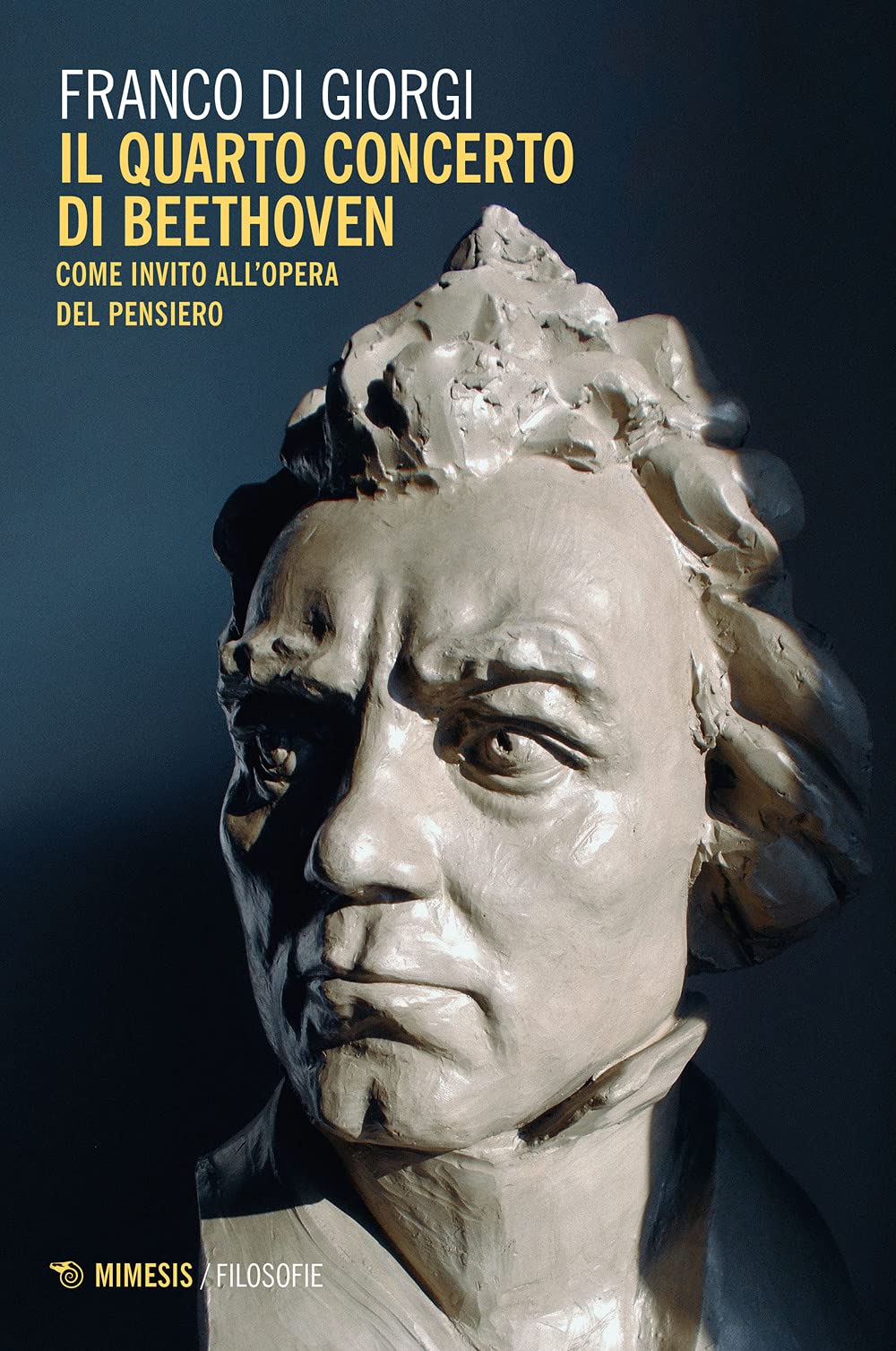

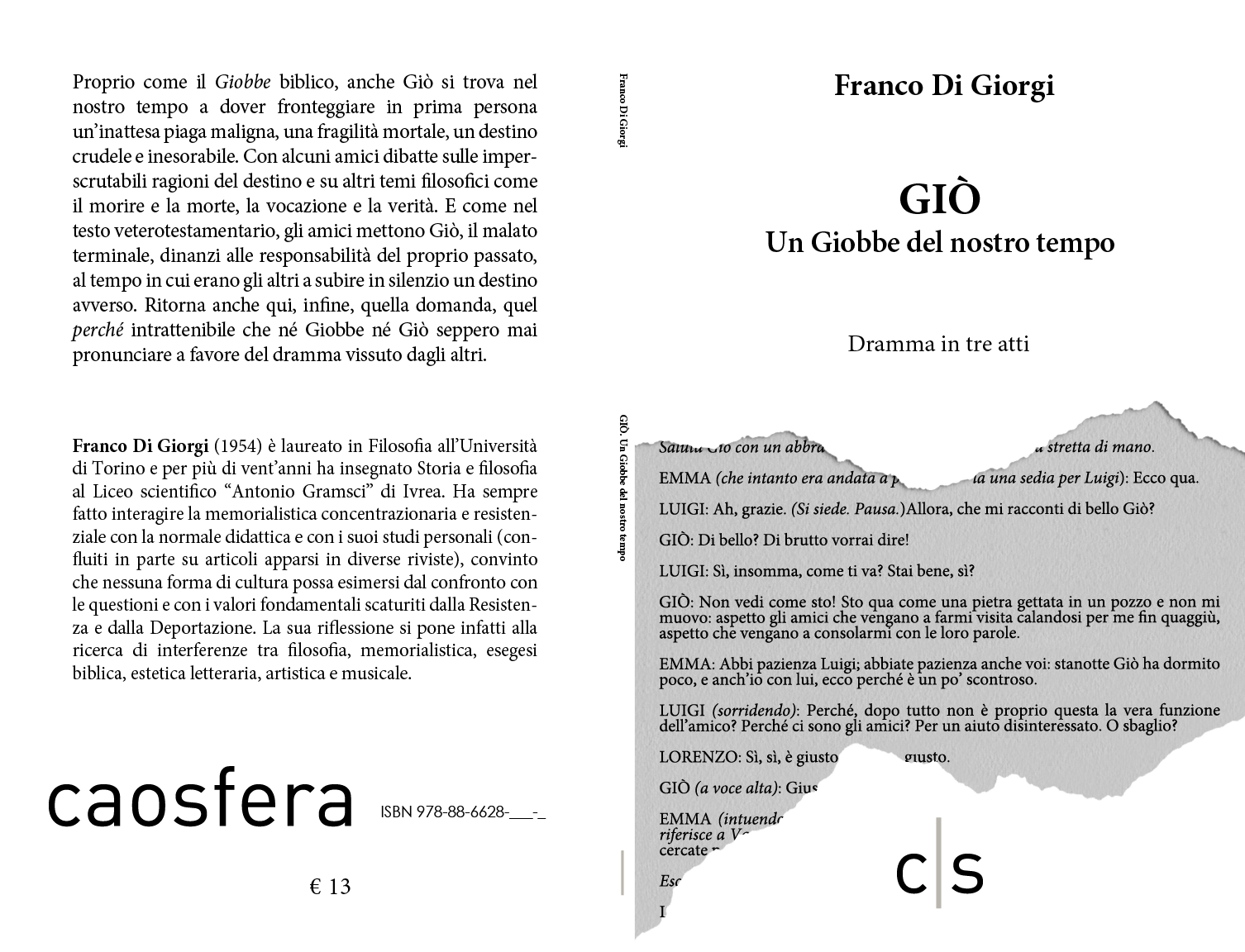






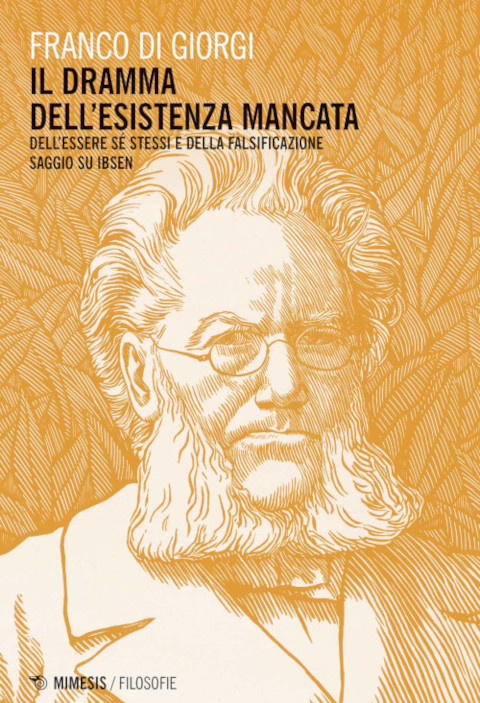 Il titolo di questo mio saggio –
Il titolo di questo mio saggio –